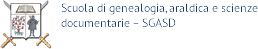LIBRO BIANCO 2000, Nuove risposte per un mondo che cambia, a cura del Ministero degli Affari Esteri, Franco Angeli editore, Milano 2000, pp. 288.
Una citazione impiegata a conforto di argomentazioni amare sulla politica in generale e sul pessimismo che non può non prodursi alla vista di come si svolgono i rapporti fra gli Stati, è quella assai nota pronunciata da Axel di Oxenstierna indirizzata al figlio Giovanni che, plenipotenziario svedese, si accingeva a recarsi al congresso di Münster per sottoscrivere il trattato, e la pace, di Vestfalia (1648): “Videbis, fili mi, quam sapientia regitur mundus”.
Il grande Cancelliere, che aveva iniziato alla politica la giovanissima Cristina, conosceva assai bene la fragilità e la mediocrità del materiale umano sul quale si esercita l’arte e la scienza del politico; ed altrettanto bene sapeva che guerre e disordini vanno prevenuti, contenuti e regolati mediante la parola e la trattativa, non esistendo in politica automatismi e forze endogene (verrebbe da dire agenti immunitari) atti a evitare lo scontro e il conflitto.
È al tempo di Vestfalia, a conclusione dell’atroce trentennio di guerre di religione che devastarono l’Europa nelle coscienze e nelle cose, che nasce la diplomazia moderna, ed essa ci ha accompagnato per trecento anni, fino agli anni Sessanta del secolo appena concluso quando prese corpo l’ipotesi che lo sviluppo dei mezzi di trasmissione della notizia da un canto, e la facilità dall’altro di spostarsi da un punto all’altro del pianeta, avessero reso obsolete le costose strutture della diplomazia tradizionale, da rimpiazzare pertanto, e al più presto, con altre più idonee alle mutate condizioni del mondo.
A dir vero, non credo che la corporazione dei diplomatici abbia mai seriamente considerato tale scenario, anche quando di esso si discuteva su grandi giornali e affollati seminari (non solo in Italia, sia chiaro): gli uomini in feluca conoscevano troppo bene la complessità della professione e la insostituibilità dei loro interventi, per temere di scivolare nella disoccupazione. Ed infatti, passato il Sessantotto, non se ne parlò più.
Di una grande riforma, invece, nel mondo della nostra diplomazia si parlava già da tempo, a causa dell’immobilismo che l’aveva caratterizzata per lunghi anni; si trattava, in gran sintesi, in termini funzionali e organizzativi, di decidere fra le due opzioni possibili della struttura ministeriale: la prima, quella esistente, basata sulla suddivisione per temi e materie, risalente nella sostanza alla riforma voluta da Mussolini nel 1928, che l’aveva preferita a quella per ripartizioni geografiche, introdotta da Carlo Sforza nel 1920; la seconda, che appunto privilegia la concretezza del dato geografico sul dato, verrebbe da dire, ideologico (direzione Europa, o America Latina, o Estremo Oriente, a fronte di direzione degli Affari politici o economico-sociali: ciò in estrema concisione e non senza chiedere venia per la rozzezza dell’esemplificazione).
Superfluo dire che si è trattato di un dibattito assai complesso, e non si è mancato naturalmente di tener conto delle esperienze altrui. Allo “stato dell’arte” può dirsi che tutti i grandi paesi adottano la struttura a ripartizione geografica, con poche eccezioni (come p.e. l’Austria, la Grecia, l’Irlanda), ove permane l’organizzazione tematica (politica, commerciale, culturale, cooperazione, etc.). Potrebbero sembrare, gli argomenti accennati, materia per causidici perditempo, e in ogni modo non tali da alimentare polemiche decennali nei luoghi deputati alla elaborazione della nostra politica estera. Non è questo il luogo per riaprire il dibattito: basti dire che oggi l’Italia, per le strutture di cui parliamo, si è dato un sistema organizzativo a forte, ma non esclusiva, connotazione geografica, nelle grandi linee comparabile a quello dei grandi paesi che da tempo lo praticano (Canada, Francia, Giappone, Germania, Russia, Spagna, Regno Unito, USA, ed altri).
Sarà di qualche interesse conoscere per sommi capi qual è l’attuale rete diplomatica e consolare italiana, non senza ricordare che nella graduatoria mondiale del PIL l’Italia oscilla tra il 5° e il 6° posto (dopo gli USA, il Giappone, la Germania, la Francia, e talvolta il Regno Unito): essa si cifra, a fine 1999, in 118 ambasciate ed occupa, in termini quantitativi, il settimo posto (USA 160, Francia 154, Regno Unito 145, Russia 140, Germania 137, Giappone 119). Si tratta, lo si comprende senza enfasi, di una struttura imponente, che ancor meglio merita tale aggettivazione ove le si metta accanto la rete consolare, la più vasta oggi esistente: ben 120 uffici, a fronte dei 103 consolati francesi, dei 96 spagnoli, dei 75 USA, dei 73 russi, dei 66 giapponesi (tale “primato” è un’esigenza imposta dal gran numero di comunità italiane nel mondo, frutto dei flussi migratori avutisi negli ultimi cento venti anni). Non è tutto: occorre ancora ricordare le dodici rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali, delle quali il gran pubblico conosce soprattutto l’ONU, la NATO, l’OCSE, l’UNESCO, l’Unione Europea, la FAO (ospitata a Roma), etc.; e infine gli ottantotto Istituti Italiani di Cultura, veicoli della nostra lingua, della cultura, dell’arte e delle tradizioni del nostro paese.
Per cogliere appieno i mutamenti avvenuti in diplomazia e nella professione diplomatica a partire dall’ultimo dopoguerra, è bene ricordare che fino a cinquanta anni fa le missioni diplomatiche si ripartivano in ambasciate e legazioni: le prime, di norma accreditate presso le grandi potenze da potenze più o meno tali, conferivano al capomissione l’appellativo di eccellenza, dal quale invece erano esclusi i capi delle legazioni, i cui titolari avevano la qualifica di ministri Plenipotenziari. Occorre dire che ambasciatori e ministri, come tali accreditati dai rispettivi governi, facevano assolutamente le stesse cose ed avevano identica capacità di rappresentanza. Nel dopoguerra i piccoli e medi paesi, che fino a quel momento avevano trovato naturale inviare e ricevere ministri plenipotenziari, furono percorsi dalla voglia matta di ospitare ambasciatori, e di inviarne, ciò che spiega perché le legazioni sono scomparse; per esemplificare, il nostro paese a inizio del 1923 disponeva di 61 missioni, di cui solo nove con rango di ambasciata*, divenute 16 su 60 missioni allo scoppio della Seconda guerra mondiale.
Questa nota sarebbe manchevole senza un cenno agli uomini e alle donne che danno vita al servizio diplomatico. Stupirà apprendere che in questi ultimi anni si è assistito ad una crisi vocazionale, così che ben sette volte su dieci non si è riusciti ad assegnare i 25 posti messi a concorso con cadenza quasi annuale.
La spiegazione è semplice: il concorso diplomatico è fuor di dubbio la prova concorsuale più difficile proposta dalla pubblica Amministrazione: superare cinque prove scritte, e orali su 10 materie significa disporre di un bagaglio di conoscenze fuori della norma, cui la libera professione o il privato propongono subito, e non dopo 15-20 anni, gratificazioni economiche ben diverse da quelle offerte dai gradi iniziali della carriera (le periodiche “rivelazioni” giornalistiche tese a “svelare” gli stipendi da nababbi dei diplomatici Italia, inesistenti in altri paesi, sono solo espressione di insopprimibile provincialismo).
Il Libro Bianco è di grande utilità per un approccio razionale ai meccanismi della nostra politica estera, come praticato dalle istituzioni a ciò delegate, in una varietà di situazioni e di problematiche che non mancheranno di interessare, e talvolta di stupire il lettore. (Giuseppe Alberto Ginex)
* Le seguenti: Berlino, Bruxelles, Costantinopoli, Londra, Madrid, Parigi, Rio de Janeiro, Tokio, Washington.